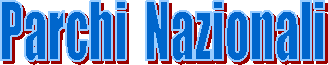
![]()
Flora
Nel
profilo indiscutibilmente unico del Delta del Po c'è il territorio creato sia
dalla sedimentazione del fiume, che dall'opera dell'uomo che nei secoli ne ha regimentato le acque e bonificato i terreni. Nell'area del
Delta, natura, storia, tradizione, cultura ed arte si intrecciano, offrendo al
visitatore un paesaggio inedito e sorprendente
Fauna
L'ambiente
del Delta limita la vita degli animali terricoli, eccetto che nei boschi e
sulle dune costiere.
E' invece un vero paradiso per gli uccelli, sia stanziali che migratori, e per
pesci e molluschi.
Per parlare della fauna del Delta del Po seguiamo un percorso che dalla
campagna procede verso le zone più prossime al mare, differenziando gli
ambienti che si incontrano e andandovi a descrivere gli animali che
maggiormente li frequentano.
Uccelli
Gli uccelli, con oltre 370 specie di nidificanti, migratori e svernanti
regolari, sono la parte più interessante della fauna del delta del Po.
Qui li identifichiamo in base agli ambienti dove è più facile trovarli.
Canali, golene fluviali,
casse di espansione
Sono
in assoluto gli ambienti più ricchi di specie per l'ampia varietà di situazioni
che presentano. Tra i canneti nidificano specie come l'airone rosso e il falco
di palude.
In alcune zone, il mignattino e il rarissimo mignattino piombato costruiscono
il loro nido di steli sulle ninfee.
Lagune e valli, barene e
dossi
Nidificano il fraticello, la sterna comune, il gabbiano reale, il gabbiano
comune e la pettegola. Sono da segnalare inoltre l'airone rosso (Ardea purpurea), la spatola (Platalea
leucoridia), l'ibis mignattaio (Plegadis
falcinellus) e la volpoca (Tadorna
tadorna).
Per gli uccelli migratori il delta è zona di svernamento e di rifugio, come per
il quattrocchi (Buccephala clangula).
Durante le migrazioni e in inverno questi ampi specchi d'acqua
si popolano di migliaia di folaghe (Fulica atra) e di
varie specie
di anatre: anatre tuffatrici, come moretta (Aythya fuligula)
e moriglione (Aythya ferina); anatre di superficie,
come germano reale (Anas platyrhynchos), codone (Anas
acuta), marzaiola , mestolone (Anas clypeata) e
fischione (Anas penelope).
Il
Delta
Detto il "dolce
gigante", il Po, il fiume più lungo d'Italia, con i suoi 650 chilometri
attraversa la pianura Padana fino all'Adriatico, dove sfocia a delta, dando
vita ad una delle più vaste zone umide europee e del Mediterraneo.
Proteso nel mare come un triangolo con l'asse sul ramo centrale del Po di
Venezia, esattamente sul 45° parallelo che è lo stesso di Torino e con i lati a
nord lungo l'Adige e a sud lungo il Po di Goro, il
Delta del Po è la porzione di territorio più giovane d'Italia.
Infatti, quella caratteristica sporgenza della parte alta dello Stivale
italiano ha iniziato a formarsi poco meno di 400 anni fa ed è in continua
evoluzione.
Evoluzione
geologica
Dal Pliocene, 10-12
milioni di anni fa, quando il mare lambiva i rilievi alpini ed appenninici, al Wurm, 75.000-10.000 anni fa, ultimo periodo glaciale, si
venne formando la pianura Padana.
La linea di costa sull'Adriatico si stabilizzò solo 5-6000 anni fa ed è da quel
periodo che possiamo seguire con buona approssimazione il processo evolutivo
della foce del Po.
Approfondimenti
Il
paesaggio
Nel profilo
indiscutibilmente unico del Delta del Po c'è il territorio creato sia dalla
sedimentazione del fiume, che dall'opera dell'uomo che nei secoli ne ha regimentato le acque e bonificato i terreni.
Nell'area del Delta, natura, storia, tradizione, cultura ed arte si
intrecciano, offrendo al visitatore un paesaggio inedito e sorprendente.
Nel Delta si distinguono vari ambienti, ognuno con caratteristiche peculiari:
la campagna con i paleoalvei, le dune fossili, gli
argini, le golene, le valli da pesca, le lagune o sacche e gli scanni. Questi
elementi del paesaggio si incontrano arrivando da est, scendendo lungo la
corrente del Po e quindi seguiremo quest'ordine per addentrarci nel Delta.
![]()
Il
Fiume e il territorio
Il fiume è sovente
l'elemento unificatore e la vera chiave di lettura delle vicende storiche,
economiche, artistiche, tecnologiche, delle vocazioni e dei condizionamenti dei
territori che attraversa, dalle sorgenti fino al mare.
L'acqua, quella particolare acqua che scorre in ciascun fiume, è la vera
interprete della vita quotidiana: risorsa idrica ed economica, fonte di
sussistenza e di reddito, indispensabile ai lavori di tutti i giorni,
necessaria alla difesa, grande via di comunicazione. Ma anche il colore del
fiume, il suo rumore, la temperatura dell'acqua, la velocità della corrente, il
clima che genera, si riflettono nel mondo esterno che brulica tutt'intorno. Il Fiume
è padre, madre, fratello, vita, morte, castigo - un dio. E ancora: è voce,
ambasciatore, nunzio, presagio. Gli uomini che vivono sulle rive dei fiumi sono
simili nel sentire ovunque, a qualsiasi latitudine, a qualsiasi livello di
civilizzazione siano giunti. Ogni fiume porta con sè
un destino, scritto nell'acqua. Bisogna parlare con un uomo di fiume, un uomo
che vive vicino ad un rivo anche piccolo, per capire quanto la sua storia si
innesti in quella del fiume e il fiume viva in lui, con quello che ha di bene e
di male, con quello che porta e porterà.
La
geologia del Sile
Nel Quaternario, era
geologica caratterizzata dall'alternanza di periodi freddi e periodi a clima
temperato, gli antichi ghiacciai del Piave e del Brenta trasportavano dalle
valli alpine alla pianura trevigiana, sparpagliandole a ventaglio, notevoli
quantità di materiale alluvionale. Dopo l'ultima glaciazione, circa 17.000 anni
fa, s'era formata una spessa coltre di depositi sedimentari: ghiaie grossolane
ed incoerenti all'uscita delle vallate, sabbie con argille fini e compatte
verso il mare.
La
Storia
I fiumi, dalla comparsa
dell'uomo sulla terra, sono stati l'arteria vitale che ha permesso la nascita,
l'insediamento e il movimento delle civiltà. Sul fiume è nato il primo mezzo di
trasporto ideato dall'uomo, la piroga che ha permesso di iniziare la
navigazione, i commerci, le conoscenze con altre culture. Il fiume Sile con l'arco della sua cultura che abbraccia i millenni,
è l'emblematica dimostrazione della nascita della civiltà e della cultura
veneta.
La straordinaria cultura che si sviluppò sulle sponde del Sile
inizia dalla fine dell'Eneolitico per estendersi all'età del bronzo e a quella
del ferro. In un ambiente, diverso da quello attuale, fatto di un ampio fiume e
di lagune, con isolotti coperti da querce colossali, fiori una cultura
palafitticola, di cui si sono trovate cospicue tracce durante gli scavi
industriali per l'estrazione di ghiaia.
La
Palude
E' sicuramente il
biotopo più ricco di specie animali e vegetali che si può incontrare nell'alto
corso del Sile. Oggi non ne restano che alcuni, anche
se significativi scampoli, mentre un tempo l'estensione della palude era considerevole
e costituiva, per gli abitanti dei villaggi limitrofi, un'importante fonte
aggiuntiva di reddito. Le bonifiche più rilevanti sono state effettuate dalla
colonizzazione veneziana di queste terre, nel 1500; le più recenti si sono
concluse negli anni '60, con indubbi vantaggi per la monocoltura estensiva, ma
gravi perdite per la complessità e la ricchezza del territorio. Nell'alto corso
del Sile cinque sono i siti in cui oggi è presente
questo biotopo: le cave delle ex Fornaci di Istrana,
la Palude di Morgano, le Buse
di Carlesso, la Palude dell'Oasi del Mulino Cervara e quella di Canizzano.
Pur essendo simili, presentano fattori di diversità: alcune sono naturali,
altre naturalizzate; alcune profonde e allagate, altre semiallagate,
o asciutte. In ognuna di esse, tuttavia, può essere osservata la struttura
tipica di questa cenosi.
Flora, Vegetazione e Fauna del Sile
L'area del Parco, nonostante la presenza umana, mantiene ancora
un discreto livello di naturalità grazie alla presenza lungo il corso del Sile di boschi idrofilo e di una diffusa presenza di polle
risorgive. Notevole valore assumono anche i grandi bacini d'acqua creati negli
anni '50 dall'escavazione in alveo. Tra questi si citano i due bacini
denominati Lago Inferiore a Lago Superiore a Quinto di Treviso e quelli posti
al confine tra i comuni di Treviso, Silea e Casier.
In tutti questi ambienti nei vari mesi dell'anno si possono effettuare una
serie di osservazioni molto interessanti. Il periodo migliore è costituito dai
mesi primaverili ed estivi quando la vegetazione presenta il massimo del suo
sviluppo. Anche durante l'inverno però si osservano importanti specie di
uccelli che, migrando dal nord Europa, sostano in questi lembi tutelati di
Parco.
In primavera
l'Oasi di Cervara si copre di un manto vegetale
costituito soprattutto da Pioppi, Salici ed Ontani all'interno dei quali si
osservano molte specie animali. Tra queste merita ricordare per la sua
abbondanza la Rana di lataste, specie endemica della
Pianura Padana. Tra gli uccelli invece, i più vistosi sono il Picchio verde ed
il Picchio rosso maggiore che nidificano dopo aver costruito i tipici fori nel
tronco degli alberi. Una miriade di Passeriformi inoltre frequenta l'area nel
periodo delle migrazioni, tra questi i più comuni sono il Luì piccolo, il Luì
verde, la Balia nera, il Pigliamosche e molti altri di facile osservazione con
l'aiuto del binocolo. Il maggiore contributo alla naturalità dell'area viene
portato dalla colonia di aironi (airone cenerino, garzetta e nitticora) che fin dalla istituzione del Parco, attira
l'interesse di molti ornitologi e birdwatchers. Alle
prime specie, ultimamente si è aggiunto l'airone guardabuoi che sta
diffondendosi sempre di più anche in Veneto.
Nel periodo primaverile si osservano anche alcune piante del sottobosco
particolarmente degne di nota, tra queste la felce Thelypteris palustris,
tipica dei sottoboschi umidi, un tempo frequente nei boschi planiziali
padani.
Nel periodo
primaverile-estivo è possibile
osservare la nidificazione della Folaga, del Tuffetto, della Gallinella d'acqua
e del più raro e maestoso Svasso maggiore. Tutte specie nidificanti lungo le
rive ed attorno i bacini più ampi del fiume. Tra gli uccelli nidificanti spicca
per importanza la nidificazione della Moretta, un'anatra tuffatrice molto rara
come nidificante in Italia.
Volgendo lo sguardo lungo le rive del fiume, si possono rilevare assembramenti
di Cavedani nonché Tinche e Carpe occupate a svolgere i rituali tipici della
riproduzione. Tutto attorno si assiste alla crescita dell'Hippuris vulgaris,
una pianta un tempo molto diffusa lungo il Sile ed
ora in via di riduzione a causa forse della modificazione dello stato delle
acque. Molto gradevoli e delicati sono anche le infiorescenze del Morso di Rana
(Hydrocharis morsus-ranae)
che si sviluppano nelle acque basse e si mescolano alle foglioline dalla Lemna minor che cresce in
abbondanza.
Nei mesi
autunnali ed invernali si assiste al fenomeno delle migrazioni
degli uccelli ed in particolare di quelli acquatici che sostano nelle aree più
aperte ed ampie del fiume.
In questo periodo si osservano Cormorani, Svassi maggiori, Tuffetti ed Anatre
come Germano reale, Moriglione, Moretta, Moretta tabaccata, Canapiglia,
Alzavola etc. ed una miriade di Gabbiani tra cui il Gabbiano reale e quello
comune che fanno sempre da padroni. Non mancano però anche i gabbiani nordici
come la Gavina e talvolta perfino lo Zafferano che temporaneamente sostano
nell'area.
In certi anni le sponde del Lago si ricoprono di un manto vegetale di color marrone-rossiccio, è l'Azolla filiculoides,
una piccola felce acquatica che svolge un fondamentale ruolo nella fitodepurazione delle acque. Si tratta in definitiva di una
moltitudine di specie animali e vegetali, che esaltano il grado di naturalità e
di biodiversità del Parco e permettono ancora una volta di godere delle
bellezze racchiuse lungo il corso del fiume Sile.
![]()
Tipo
di ambiente
Ambiente
forestale alternato a praterie; presenza di casere
Animali
osservabili
Passeriformi
di passo (fringuello, peppola, lucherino, verdone, tordo bottaccio, tordo
sassello, cesena, ecc.), picchio nero, picchio rosso maggiore, poiana,
capriolo, volpe.
Attrezzatura
necessaria
Sono
consigliati gli scarponi
Note
Per
l'osservazione dell'avifauna di passo, si consiglia di sostare con un binocolo
in punti panoramici
La Flora
Non vi è
dubbio che una delle principali motivazioni scientifiche della nascita del
Parco risieda nella grande ricchezza e rarità della flora.
Fin dal 1700 le Vette di Feltre, e anche il M. Serva, godettero di meritata
fama e furono visitate da alcuni tra i maggiori botanici del tempo.
La flora vascolare (piante con fiori ed altre, come le felci, dotate di radici,
fusto e foglie) ha una consistenza di circa 1.400 entità (1/4 della flora
dell'intero territorio nazionale) e tra queste non sono poche quelle che
meritano di essere ricordate perché endemiche, rare, o di elevato valore
fitogeografico.
La parte più meridionale è la più ricca in quanto meno devastata dalle
glaciazioni e sono quindi potute sopravvivere specie antiche.
Molto numerose sono le presenze localizzate di specie rare o che qui si trovano
al confine del proprio areale.
Oltre al contingente alpino propriamente detto (e in particolare di quello
orientale), boreale ed eurasiatico - temperato, ben rappresentate sono le
specie a gravitazione orientale (illiriche, pontiche, sud-est europee) e quelle
delle montagne circummediterranee (mediterrraneo-montane).
La Fauna
Le Dolomiti
Bellunesi comprendono una grande varietà di ambienti che consente a moltissime
specie animali di trovare le condizioni adatte per vivere e riprodursi.
Ben 114 sono le specie di uccelli che nidificano nel Parco, 20 le specie di
anfibi e rettili presenti. Oltre 3.000 i camosci e più di 2.000 i caprioli.
Quasi 100 le specie di farfalle diurne e circa 50 le specie di coleotteri carabidi.
Esistono anche alcuni importanti endemismi esclusivi (specie che vivono solo
qui i tutto il mondo) fra gli insetti che popolano le cavità carsiche. Il
grande fascino degli animali di montagna risiede proprio nella loro capacità di
vivere in condizioni difficili, spesso estreme. Il gelo invernale, la scarsità
di cibo, il vento sferzante e le forti radiazioni solari vengono affrontati
grazie a mirabili strategie di adattamento.
Così, ogni ambiente, se osservato con attenzione, ci rivela una grande
ricchezza di forme animali, meravigliosa ma spesso invisibile a chi non vi si
avvicina con pazienza e rispetto.
Le Montagne
Le Dolomiti
Bellunesi, distretto sud-orientale delle Alpi Dolomitiche, costituiscono una
complessa catena montuosa che decorre dalle Vette di Feltre alla Schiara e che si affaccia su una delle più grandi vallate
alpine (media valle del Piave). La complessità strutturale e la relativa varietà
delle rocce si riflettono in una spiccata frammentazione orografica, nella
grande varietà di paesaggi e in una notevole diversità biologica.
- Vette di Feltre
- Gruppo del Cimonega
- Gruppo di Brendol
- Monte Pizzocco
- Monti del Sole
- Gruppo della Schiara
- Monte Pramper
- Monte Talvena
![]()
Tutele e vincoli di protezione della Laguna di Venezia
La laguna di Venezia è uno degli ecosistemi lagunari più estesi (550 Kmq di
superficie) e più importanti d'Europa e dell'intero bacino Mediterraneo, un'area
umida naturale con un immenso patrimonio biologico, faunistico e floristico e con alcune specie animali e vegetali rare o
minacciate d'estinzione.
Ma non solo questo. Forse in nessun altro luogo nel nostro Paese si trovano
condensati in modo così eloquente eccellenze archeologiche, architettoniche,
naturalistiche e della cultura tradizionale, come nella Laguna di Venezia. E
più che altrove qui si percepisce la fragilità e la complessità dell'insieme.
Essa è il risultato della combinazione tra fattori naturali e fattori antropici
che storicamente hanno determinato l'assetto attuale; natura e cultura in una
combinazione inscindibile e molto spesso virtuosa.
La conservazione della natura nel particolare contesto della laguna veneta deve
allora passare attraverso il mantenimento delle attività umane, così come
l'obiettivo della sopravvivenza delle comunità lagunari non può prescindere
dall'impegno per l'arresto dei processi di degrado ambientale ed il recupero
dell'equilibrio dinamico dell'ecosistema lagunare.
L'eccezionale valenza di questo territorio merita di essere valorizzata e
protetta.
Tutta l'area lagunare è stata infatti già designata come Patrimonio mondiale
dell'umanità dall'UNESCO, individuata quasi interamente come Sito di Importanza
Comunitaria e Zona di Protezione Speciale nell'ambito della Rete Natura 2000
dalla Commissione europea, messa sotto tutela dalla Legge speciale dello Stato
n°171/73 e successive e indicata come area da sottoporre a tutela
paesaggistica e quale area Parco naturale regionale dalla Regione Veneto
attraverso il PTRC (ancora vigente) e il PALAV, proposta quale area Ramsar "zona
umida di importanza internazionale" e oggetto di numerose proposte di
legge per la creazione di un grande Parco naturale ai sensi della Legge
nazionale sui parchi n°394/91.
L'istituzione di una vasta area di tutela nella laguna di Venezia segnerebbe
una svolta nelle politiche urbanistiche veneziane e rappresenterebbe un fatto
di civiltà per l'intera comunità nazionale. E' noto che le istituzioni di
governo nazionali si sono interessate alla salvaguardia di Venezia solo per
quanto riguarda gli aspetti idraulici (in particolare per la realizzazione
della maxi dighe che dovranno servire a sbarrare il mare) e poco o nulla è
stato fatto per salvaguardare le funzionalità ecologiche più generali della
laguna.


SCHEDE DELLE SPECIE NOTEVOLI
Naturalità e biotopi del territorio di Caorle e della bonifica bibionese
Le profonde
trasformazioni ambientali subite dal territorio di Caorle
a opera dell’uomo, caratterizzate da un crescendo esponenziale nel corso degli
ultimi due secoli, farebbero supporre che la naturalità dell’area avesse subito
un drastico ridimensionamento.
In realtà, se questo s’è verificato, s’è comunque trattato di un fenomeno
manifestatosi in termini disomogenei, così come disomogenea risulta oggi la
fisionomia dell’ambiente caprulano. L’antica
naturalità lagunare e palustre ha infatti trovato adeguato rifugio e continuità
nel comprensorio vallivo, ma anche lungo i grandi canali della bonifica, anticamente
lagunari, nei fossi della stessa campagna di bonifica e ancora, nei residui
biotopi propriamente lagunari e in quelli del litorale sabbioso. Una nuova
componente naturalistica, di tipo soprattutto faunistico, è stata inoltre
spontaneamente introdotta mediante il prosciugamento e la messa a coltura delle
grandi distese palustri. Si tratta della fauna delle colture e degli ambienti
agrari aperti, nonché di quella legata alle abitazioni rurali sparse e,
inoltre, della flora micologica delle pinete litoranee.
Una descrizione della naturalità propria del comprensorio di Caorle e delle bonifiche bibionesi,
prescindendo dalle valli da pesca, i cui caratteri naturalistici e d’ambiente
saranno oggetto di uno specifico paragrafo, deve dunque riferirsi ai biotopi
più significativi dell’area. Questi stessi si distinguono in: biotopi
fluviali, biotopi lagunari, biotopi agrari, biotopi
complessi.
Biotopi
fluviali
Appartengono
a questo gruppo l’alveo del canale Nicesolo,
il canale dei Lovi, i canali della
Litoranea Veneta e il canale Lugugnana.
Le caratteristiche d’ambiente dei vari biotopi fluviali risultano omogenee.
Particolare interesse presentano i canneti di sponda, che nel caso del Nicesolo ospitano autentiche rarità botaniche come l’ibisco
litorale (Kosteletzkya pentacarpos)
e il lino acquatico (Samolus valerandi), nonché interessanti presenze faunistiche.
Tra queste spiccano i pesci, con il cefalo (Mugil
cephalus), la cheppia (Alosa fallax nilotica), la spigola (Dicentrarchus
labrax) e l’anguilla (Anguilla anguilla);
specie la cui densità determina una intensa attività piscatoria professionale e
amatoriale.
Di particolare significato ecologico sono inoltre, tra gli uccelli, l’airone
rosso (Ardea purpurea), nidificante in
colonia, il falco di palude (Circus aeruginosus),
il tarabusino (Ixobrychus
minutus) e il basettino (Panurus
biarmicus), anch’essi nidificanti, oltre a
numerose altre specie che si rifugiano in questi stessi biotopi nel corso delle
migrazioni.
Biotopi
lagunari
Appartengono
a questo gruppo gli invasi delle due bocche di porto Porto
Baseleghe e Porto Falconera,
nonché l’ampia fascia barenicola e palustre della Palude
delle Zumelle.
Si tratta dei soli biotopi propriamente lagunari conservatisi nel territorio di
Caorle. Come tali essi sono caratterizzati da bassi
fondali melmosi, da immissari di acque dolci e da dinamiche idrauliche
direttamente correlate con i flussi di marea, oltre che da apparati insulari
tipicamente piatti e soggetti alle esondazioni delle maree più elevate.
La dotazione naturalistica delle stesse sacche lagunari e della profonda fascia
di barena salmastra della Palude delle Zumelle (autentico transetto dell’antico
ambiente lagunare) presentano complessità e livello eccezionali. La componente
floristica si caratterizza per la presenza di alofite erbacee e suffruticose
(cespugli), tra cui l’endemica salicornia veneta (Salicornia veneta),
l’assenzio di laguna (Artemisia coerulescens),
la piantaggine di Cornut (Plantago
cornuti), il limonio del Caspio (Limonium bellidifolium),
il limonio comune (Limonium
serotinum), che forma autentiche distese fiorite
nel cuore dell’estate, lo sparto di laguna (Spartina
marittima) e l’astro di laguna (Aster tripolium).
La componente faunistica risulta caratterizzata da una densa presenza di
invertebrati bentonici (vermi, molluschi, crostacei), che attirano migliaia di
uccelli in tutte le stagioni. Spicca per importanza, tra gli ambiti lagunari,
la sacca di Porto Baseleghe, autentico biotopo
d’interesse faunistico continentale per la sosta dei limicoli migratori. Le
popolazioni di piovanello pancianera (Calidris
alpina), di pivieressa (Pluvialis squatarola), di chiurlo piccolo (Numenius
phaeopus) e di beccaccia di mare (Haematopus ostralegus)
sono infatti tra le più consistenti dell’Adriatico settentrionale. A queste si
aggiungono uccelli piscivori come il beccapesci (Sterna sandvicensis)
e la sterna comune (Sterna hirundo) e i
fitofagi, rappresentati da concentrazioni di cigno reale (Cygnus
olor) fino a 290 individui.
Non meno significativa è, infine, la presenza di pesci lagunari ed eurialini,
con specie bentoniche come i gobidi ghiozzetto di laguna (Knipowitschia
panizzai) e ghiozzetto
cenerino (Pomatoschistus canestrinii).
Biotopi
agrari
ppartengono
a questo gruppo le risaie del Quarto Bacino di Bibione.
Si tratta di un biotopo agrario del tutto particolare e assimilabile a una
palude dolce temporanea, con il vantaggio su questa di una disponibilità
trofica assai elevata, soprattutto nelle fasi estreme della semina e del
raccolto del riso.
Le stesse risaie del Quarto Bacino, tra l’altro, costituiscono uno degli ultimi
esempi di coltura storica legata all’ambiente palustre e di bonifica.
In questo caso l’interesse del biotopo risulta eminentemente faunistico; vi si
rinviene infatti una elevata densità di anfibi e in particolare di rana verde (Rana
synk. esculenta), nonché una notevole presenza di
uccelli. Assai interessante è, ad esempio, la popolazione di folaga (Fulica atra) nidificante, oltre a quella di
cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus), di garzetta (Egretta garzetta), di
airone cenerino (Ardea cinerea) e di
airone bianco maggiore (Egretta alba), specie queste ultime che
ricercano cibo nelle acque basse.
Biotopi
complessi
Appartiene
infine a quest’ultimo gruppo il complesso ambientale di Valle Vecchia,
che costituisce un mirabile mosaico di biotopi di duna litoranea, di pineta, di
bosco igrofilo, di palude dolce e di monocoltura agraria.
L’ambiente di Valle Vecchia assume peraltro un valore emblematico nel contesto
territoriale considerato: esso ha costituito, infatti, l’ultimo bacino palustre
a essere prosciugato (metà degli anni Sessanta), ma anche il primo a essere
interessato da uno specifico intervento di riqualificazione ambientale,
mediante rimboschimento ma anche con il riallagamento
di alcune superfici agrarie (circa 60 ha complessivi).
Allo stato attuale Valle Vecchia costituisce dunque un esempio unico di
diversità ambientale e di compatibilità tra produzione e conservazione,
ottenute con l’adozione di soluzioni d’avanguardia come la realizzazione di
siepi e di filari arborei, di boschi igrofili, di bacini d’acqua dolce e
salmastra, di canneti, nonché di bacini di fitobiodepurazione.
Tutto questo alle spalle di un complesso d’ambiente litoraneo formato da
arenile sabbioso, dune aperte, avvallamenti interdunali
e dune fossili con pineta.
La naturalità di Valle Vecchia risulta pertanto notevolissima, sia per la
componente floristica e vegetazionale, sia per la
componente faunistica. Tra le specie floristiche spiccano, ad esempio, l’astro
spillo d’oro (Aster linorirys), le vedovelle dei prati (Globularia punctata),
l’aglio odoroso (Allium suaveolens),
il gladiolo palustre (Gladiolus palustris), il falasco (Cladium
mariscus), oltre a numerose specie di orchidacee
e a specie psammofile come lo zigolo delle sabbie (Cyperus
kally) e la soldanella di mare (Calystegia soldanella).
Notevoli, per l’aspetto vegetazionale, sono inoltre i
molinieti (formazioni erbacee a Molinia
altissima), che ricoprono le depressioni interdunali
più vaste.
Per gli aspetti faunistici, con riferimento ai soli vertebrati, va sottolineato
il dato relativo alla presenza di circa 240 specie (comprese le sacche lagunari
periferiche) nelle quattro stagioni; tra queste circa 200 sono rappresentate da
uccelli. Arduo, in questo caso, citare le specie di maggiore interesse; esse
comprendono, escludendo l’avifauna, la rana di Lataste
(Rana latastei), il rospo comune (Bufo bufo), la
vipera comune (Vipera aspis), il toporagno
acquatico di Miller (Neomys anomalus), l’arvicola del Liechtenstein (Microtus liechtensteini),
il tasso (Meles meles)
e la puzzola (Mustela putorius). Tra gli
uccelli, infine, le stesse specie notevoli sono decine e decine; si pensi alla
moretta tabaccata (Aythya niroca), al fistione turco (Netta
rufina) nidificante, alla pernice di mare (Glareola praticola), all’avocetta (Recurvirostra avosetta),
al fraticello (Sterna albifrons), al fratino (Charadrius alexandrinus),
alla quaglia (Coturnix coturnix),
all’averla cenerina (Lanius minor) e
alla salciaiola (Locustella
luscinioides), tutte nidificanti e a decine di
altre ancora.
![]()
Geologia
Il gruppo del Gran
Paradiso è costituito da rocce di varia età e provenienza. In particolare vi si
trova un complesso di gneiss stratificati (rocce metamorfiche derivate da
graniti o da dioriti, ancora conservati qua e là). In alcuni casi gli gneiss
hanno uno spesso ricoprimento di scisti calcarei variamente metamorfosati,
derivati da sedimenti marini dell'era mesozoica. Da segnalare la presenza di
ricchi filoni di minerale di ferro in Val di Cogne che ha notevolmente
influenzato la vita delle popolazioni della vallata.
Il
patrimonio culturale
Villaggi e alpeggi
raccontano la lunga storia della civiltà dei pastori. Popolazioni che per
centinaia di anni sono vissute autosufficienti su queste montagne, con
frequenti contatti con le genti oltr'alpe piuttosto
che con le popolazioni della pianura. Le abitazioni del versante piemontese
sono costruite interamente di pietra, mentre sul versante aostano si affianca
il legno. Il modello più comune, con le dovute varianti a seconda della valle,
prevede un edificio in pietra e legno con in basso la stalla, al primo piano
l'abitazione e al di sopra il fienile, in modo da mantenere i locali abitativi
più al caldo possibile. Il Parco si prefigge anche di valorizzare il patrimonio
culturale della montagna e favorirne un certo sviluppo economico compatibile
con l'ambiente.
Fauna
e Flora
Simbolo del Parco, lo
stambecco (Capra ibex) è piuttosto confidente e non è difficile
osservarlo al pascolo nei prati alpini. I maschi, riconoscibili dalle lunghe
corna ricurve, vivono in piccoli gruppi, mentre le femmine, dalle corna più
corte, e i piccoli formano branchi separati.
Quasi sempre si ascolta il suo fischio prima di vederla: è la marmotta, un
simpatico roditore degli ambienti montani. Con le forti unghie scava lunghe
gallerie nel terreno che le consentono di nascondersi all'arrivo di un pericolo
e di trascorrere l'inverno in letargo.
Scomparso dal Parco nel 1912, il gipeto (Gypaetus barbatus)
sta ritornando sull'arco alpino grazie a un progetto di reintroduzione
internazionale. Nella zona nidifica invece un altro grande rapace, l'aquila
reale, non poi così difficile da osservare.
Come dice il nome, il crociere (Loxia curvirostra) è
caratterizzato dal becco con le punte che si incrociano, peculiarità che gli
permette di far leva sulle pigne per estrarne i semi. E' un uccello tipico dei
boschi di conifere.
L'unica conifera a perdere gli aghi in autunno, il larice (Larix decidua) è una pianta
pioniera, capace di crescere in breve tempo anche sui terreni nudi dell'alta
montagna, dove la vegetazione è quasi assente.
Simbolo dell'alta montagna, la stella alpina (Leontopodium alpinum)
è diffusa dai 1500 ai 3200 metri di altezza. Piuttosto localizzata, questa
pianta è caratterizzata da una soffice peluria che ricopre il lato superiore
delle foglie.
Il giglio di monte (Paradisea
Liliastrum) è stato scelto come simbolo
per il giardino botanico Paradisia di Valnontey (Cogne), un'esposizione all'aperto della flora
alpina.
La
Storia
Le vicende del Parco
sono indissolubilmente legate alla protezione dello stambecco. Già nel 1856 il
re Vittorio Emanuele II aveva dichiarato Riserva Reale di Caccia una parte
dell'attuale territorio del Parco, salvando in questo modo dall'estinzione lo
stambecco che in quegli anni aveva ridotto la sua popolazione a livelli
allarmanti. Il re aveva poi formato un corpo di guardie specializzate e fatto
costruire sentieri e mulattiere che ancora oggi costituiscono la migliore
ossatura viaria per la protezione della fauna da parte dei guardaparco e
formano il nucleo dei sentieri escursionistici. Nel 1920 il re Vittorio
Emanuele III donava allo Stato italiano i 2.100 ettari della riserva di caccia.
affinché vi creasse un parco nazionale. Due anni dopo, il 3 dicembre, veniva
istituito il Parco Nazionale del Gran Paradiso, il primo parco nazionale
italiano. L'area protetta fu gestita fino al 1934 da una commissione dotata di
autonomia amministrativa. quindi direttamente dal ministero dell'Agricoltura e
foreste fino a dopo la Seconda Guerra Mondiale (subendo purtroppo gravissimi
danni durante la guerra) e ancora da un ente autonomo a partire dal 1947. Nel
1991 è stata promulgata una legge quadro sui parchi, uno strumento legislativo
indispensabile per regolare la nascita e la vita delle aree protette in Italia,
compreso il Parco del Gran Paradiso.
![]()
|
LA FAUNA:
Arvicola delle nevi
(Microtus nivalis)
Camoscio (Rupicapra rupicapra)
Capriolo (Capreolus capreolus)
Cervo (Cervus elaphus)
Donnola (Mustela nivalis)
Ermellino (Mustela erminea)
Faina (Martes foina)
Lepre alpina (Lepus timidus)
Lontra (Lutra lutra)
(E)
Lince (Felis lynx)
(E)
Lupo (Canis lupus) (E)
Marmotta (Marmota marmota)
Martora (Martes martes)
Orso bruno (Ursus arctos) (E)
Scoiattolo (Sciurus vulgaris)
Stambecco (Capra ibex)
Talpa (Talpa europaea)
Tasso (Meles meles)
??
Volpe (Vulpes vulpes)
Aquila reale
(Aquila chrysaetos)
Corvo imperiale (Corvus corax)
Coturnice (Alectoris graeca)
Cuculo (Cuculus canorus)
Falco pellegrino (Falco peregrinus)
Francolino di monte (Tetrastes bonasia)
Gallo maggiore o cedrone (Tetrao urogallus)
Gallo minore o forcello o Fagiano di monte (Lyrurus tetrix)
Gheppio (Falco tinninculus)
Ghiandaia (Garrulus glandarius)
Gipeto (Gypaetus barbatus)
Gracchio alpino (Pyrrhocorax graculus)
Gufo reale (Bubo bubo)
Nocciolaia (Nucifraga caryocatactes)
Pernice bianca (Lagopus mutus)
Picchio nero (Dryocopus martius)
Picchio rosso maggiore (Dryobates major)
Poiana (Buteo buteo)
Piviere tortolino (Charadrius morinellus)
|
|
|||||||||
|
Se
gli animali costituiscono per molti il motivo di una visita al Parco, la
vegetazione e la flora rappresentano una bellezza che spesso colpisce e
emoziona non meno dell'avvistamento di uno stambecco o di un'aquila.
|
|||||||||
|
Abete bianco (Abies alba)
Abete rosso (Picea excelsa)
Betulla (Betula verrucosa)
Larice comune (Larix decidua)
Ontano bianco (Alnus incana)
Ontano nero (Alnus glutinosa)
Pino cembro o Cirmolo (Pinus
cembra)
Pino mugo (Pinus mugo, Pinus
montana)
Pino silvestre (Pinus sylvestris

























